Se allo scatenarsi dell’emergenza Covid, nel momento della chiusura delle scuole e della necessità di affidarsi a strumenti alternativi, tutti raccolti sotto la sigla DAD, ci siamo chieste come fosse possibile continuare a lavorare sulla relazione educativa e sull’educazione ai sentimenti, adesso dopo due mesi di lockdown, stremate da una didattica che chiede sforzi immani per risultati minimi, ci si trova di fronte al lavoro di fine anno di scrutinare le classi e valutare gli alunni. Una mission impossible?
Andiamo con ordine. La didattica a distanza si è rivelata uno strumento straordinario, su questo siamo tutte d’accordo. Meno male che c’era. In alcune scuole le video-lezioni sono iniziate a tempi record e una gran quantità di alunni hanno potuto proseguire, anche se in maniera diversa, il loro percorso di apprendimento. Ma solo in “alcune” scuole e per una “gran quantità” di alunni, non per tutti. Primo problema: la estrema diversità dell’”offerta formativa” sul territorio. Ci sono esempi positivi di alunni “recuperati” dalla didattica a distanza, anche tra quelli con disabilità, ma anche tanti esempi facilmente immaginabili di alunni “persi”, che si sono auto-oscurati, che non si sono collegati, vuoi perché così preferivano, vuoi perché sforniti dei giga e degli apparecchi necessari. In ogni caso la DAD è uno strumento per l’emergenza e, al massimo, utile per integrare un percorso educativo. La DAD da sola non può sostituire la scuola. Non si può costruire una proficua relazione educativa se non in presenza, e la relazione già esistente non può essere adeguatamente sviluppata e alimentata se non in presenza. Con la DAD si possono spiegare contenuti, fare domande, anche fare verifiche e scambiare idee e sentimenti, ma in maniera fortemente limitata dalla mancanza della presenza fisica. Il maestro Manzi a suo tempo (con la televisione, la DAD di allora) fece prendere il diploma elementare a un milione e mezzo di cittadini, ma era coadiuvato da migliaia di maestri che aiutavano gli “alunni” in presenza. Inoltre questo strumento ha determinato necessariamente il “ritorno in famiglia” degli studenti, inevitabile, ma deleterio in quanto compromette compromette il processo di individuazione degli adolescenti.
E inoltre come valutare?
Partiamo da cosa si può valutare. Si può certamente valutare il percorso. L’insegnante è in grado di descrivere il processo di crescita e la partecipazione, la disponibilità di ciascun alunno. Cioè si può fare la valutazione formativa. Questa valutazione è quella, per noi che ci occupiamo di relazione educativa, centrale. Si terrà conto dei disagi che bambini e adolescenti hanno sperimentato in questo periodo, delle difficoltà anche tecniche in cui si sono trovati. E tuttavia accertare il livello di competenze raggiunte con la DAD ha dei limiti di affidabilità, data la difficoltà di verificare la correttezza degli studenti nello svolgimento delle prove. Lo capisce chiunque.
Il ministero, nella sua politica ondivaga, prima dice di ammettere tutti alla classe successiva e “rimanda” l’accertamento entro la fine del successivo anno scolastico, poi dice di bocciare quelli con insufficienze gravi già dal primo quadrimestre, creando ulteriore confusione. Questa situazione di emergenza, infatti, accentua drammaticamente un problema già esistente nella scuola per la valutazione, dove spesso si confondono conoscenze, competenze e abilità, oltre a mettere sullo stesso piano la valutazione formativa e quella delle competenze. Il risultato è che chi avrà sei penserà semplicemente di avere avuto la sufficienza. Punto. E la preparazione reale dei ragazzi sarà inferiore a quella solita.
In realtà l’anno scolastico è stato quasi dimezzato, il secondo quadrimestre era iniziato da poco quando le scuole sono state chiuse. In secondo luogo scrutinare e attribuire voti può far pensare che in fondo con la DAD si può fare tutto, tutto quello che normalmente si fa a scuola: lezione e verifiche. E non è vera né l’una né l’altra cosa, come abbiamo detto. Questo significa che se il virus prosegue la sua corsa ci potremmo ritrovare di fronte, invece di classi meno numerose, come sarebbe auspicabile, classi anche più numerose, tanto sulle piattaforme online c’entriamo in tanti.
Mai come adesso il ruolo della Scuola (come quello della Sanità) dovrebbe essere chiaro a tutti. Tutti dovrebbero aver capito che i tagli alla scuola pubblica (come quelli alla Sanità) sono stati una sciagura. Adesso è il momento di investire di nuovo, diminuire il numero di alunni per classe, trovare anche altri luoghi per la scuola, e ampliare l’organico del corpo docente e ATA. Finora si è solo sovraccaricato gli insegnanti (e non solo, tutto il mondo della scuola) di lavoro extra e responsabilità. I docenti hanno dovuto inventare soluzioni da zero, si sono dovuti sobbarcare un lavoro di nuovo tipo che si è scoperto crea un nuovo tipo di stress (zoom fatigue), cambiare il tipo di didattica, tentare di proseguire il percorso in assenza di strumenti adatti allo scopo. Fare scuola con metà alunni in classe e metà a casa in modalità DAD sarebbe un modo di continuare questa politica: scaricare sugli insegnanti tutti i problemi senza cercare di affrontarli. In altre parole, pur capendo la difficoltà del momento, dal ministero non arriva una direzione chiara. Persino le istruzioni per gli esami delle classi terminali sono in ritardo e confuse, cosa che a fronte del lavoro e dello sforzo onestamente profuso suona quasi offensiva. Sembra che al ministero, alla base, non ci sia un’idea di scuola. Almeno non un’idea condivisibile.
Infine la questione della riapertura delle scuole. Le scuole vanno riaperte in sicurezza, su questo non ci piove. Ma il fatto che la chiusura ricada principalmente sulle spalle delle donne, ancora fortemente sfavorite nel mondo del lavoro, non può essere taciuto. Riaprire le attività lavorative e tenere chiuse le scuole significa costringere le donne a stare a casa con i figli, né più né meno. E allora, visto che le mamme non sono solo genitrici, ma persone che fanno anche altro, visto che le insegnanti di ogni ordine e grado sono professioniste della pedagogia e della didattica e non possono essere schiacciate sul ruolo di baby-sitter, si tratterà di chiedere agli uomini di mettersi in congedo parentale, di chiedere ai datori di lavoro di favorire queste soluzioni e al governo di supportare queste scelte.
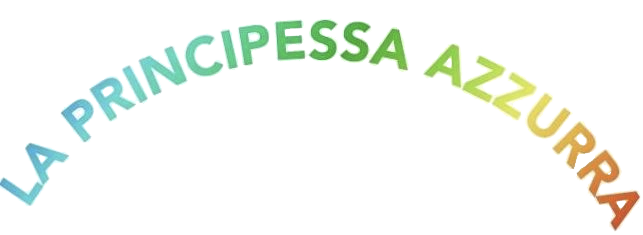

Lascia un commento