
Letture in immersione
a cura di
Mara Fortuna
Curiosate, sfogliate, cercate le parole per dirlo e fatele volare, che è per questo che sono nate, per volare di bocca in bocca

“CASSANDRA A MOGADISCIO” di Igiaba Scego (ed. Bompiani)
di Mara Fortuna
“Amatissima, come si disegna la tua risata?”.
Così, con un potente richiamo al celeberrimo “Amatissima” di Toni Morrison, inizia il nuovo romanzo di Igiaba Scego, “Cassandra a Mogadiscio” (ed. Bompiani), entrato per direttissima nei magnifici dodici del Premio Strega 2023. Dopo “La linea del colore” (Premio Napoli 2020) in cui la vita di una pittrice di colore veniva affiancata a quella di una giovane italo-somala, in cui già era ben presente il tema della diaspora dei Somali (e di quanti altri?), l’autrice con questo nuovo lavoro affronta senza mezzi termini il nocciolo duro: l’identità, l’appartenenza, la propria storia (e il suo inevitabile intrecciarsi con la Storia), spezzate e frantumate dalle guerre. Affronta il dolore generatore di quello che chiama Jirro, in somalo “malattia”, qui usato per indicare il grande male causato dalla guerra e dalla diaspora.
È un libro molto speciale, questo, che mette in crisi, e nel profondo, una italiana come me. Non si tratta solo di conoscere la Storia, di avere cognizione del colonialismo e coscienza che noi non siamo “i buoni”. C’è altro.
“L’italiano, la lingua di chi ha colonizzato i nostri antenati a Brava come a Mogadiscio, una lingua un tempo nemica, un tempo negriera, ma che ora è diventata, per una generazione che va da mia madre a me, la lingua dei nostri affetti. Dei nostri più intimi segreti. La lingua che ci completa nonostante le sue contraddizioni. Lingua di Dante, Petrarca, Boccaccio, Elsa Morante e Dacia Maraini. Lingua di Pap Khouma, Amir Issaa, Leila Houssi, Takoua Ben Mohamed e Djarah Kan. Lingua un tempo singolare e ora plurale.”
Piccolo paragrafo, grande verità. Diciamocelo: chi, davvero, è consapevole di questo? Chi pensa alla letteratura italiana come a una letteratura plurale? L’italiano è per Scego, come per chi l’ha preceduta e chi la seguirà, la lingua dell’intimità, la lingua che ama e in cui scrive, la lingua in cui nella mente si formano i pensieri. E tuttavia in questo romanzo, che è una lunga lettera alla nipote (Soraya Scego, interprete del ruolo di Waris Dirie – modella di origine somala – da bambina nel bel film “Fiore del deserto”), l’autrice non rinuncia al somalo. Ogni capitolo è titolato in entrambe le lingue, nella narrazione i nomi dei familiari, madre, padre, zii sono anche in somalo: primo tra tutti hooyo, mamma, e poi aabo, papà, edo, zia paterna, habaryar, zia materna, cioè piccola madre. E spesso alcuni termini o frasi sono riportati anche in somalo. Wallahi, te lo giuro. Harambaro, scarafaggi. Shaqo, lavoro. Così nella sua lingua del cuore, un italiano capace di accogliere la lingua dell’origine, ricama, come un arazzo, come uno dei coloratissimi maro che la madre cuce, la storia di famiglia e la sua propria.

Il punto di partenza è il Capodanno 1990. Lei, adolescente, si sta preparando per andare alla festa con i suoi amici e aabo, guardando la tv, resta pietrificato: in Somalia è scoppiata la guerra civile. Lì si trova la madre, “l’unica ottimista in un paese in cui tutti erano diventati improvvisamente pessimisti. Lei credeva che la Somalia avesse un futuro”, scrive l’autrice. È andata, fiduciosa, a trovare la sorella. Da quel momento di lei per un anno non sapranno più niente, e Igiaba ne soffrirà fino ad ammalarsi, vomiterà tutto quello che mangia, il cibo, per lei, è diventato come le bombe e i kalashnikov, le armi che con il loro frastuono hanno inghiottito hooyo.
L’inizio della guerra civile, il suo dipanarsi, la distruzione completa della loro terra, di Mogadiscio, la città bianca, si intreccia al racconto del tempo precedente. Scego scrive del colonialismo e del periodo di Siad Barre, della fuga dei suoi genitori e di tanti altri, la diaspora. Improvvisamente poveri, sconcertati dall’accorgersi che l’Italia non è esattamente una patria, come l’avevano sentita, si ritrovano soli, lontani dai figli che hanno dovuto lasciare, dai parenti che, come quelli di tutti i rifugiati, sono sparsi sui cinque continenti, parlano lingue diverse, comunicano solo attraverso telefonate e video. È a questo punto che nasce Igiaba, all’inizio degli anni settanta, e abita in pensioni modeste, tristi, conosce le privazioni. Questo libro, però, non è solo la sua storia. È la storia del padre, che da diplomatico affascinante, esponente di rilievo del suo paese, precipita nella povertà e nell’invisibilità, lontano dai suoi figli. È la storia della madre, che da bambina cresce nella boscaglia curandosi dei dromedari, poi arriva a Mogadiscio, passa attraverso la tortura dell’infibulazione (una pratica orribile e domestica, abituale, che la zia si affretta a far eseguire per far un piacere alla madre), impara a leggere, sposa aabo e infine lo segue nell’esilio, percorre la sua stessa parabola. Hooyo, che ricama arazzi e che vuole raccontare a Soraya la sua storia, la storia della famiglia, ma non può farlo, non hanno lingue in comune. E chiede a Igiaba.
Ecco la struttura del romanzo. Igiaba scrive a Soraya per raccontare ciò che hooyo racconta. La madre, le sue parole, sono l’archivio storico che l’autrice consulta e interroga continuamente. In Somalia gli archivi sono bruciati, non è rimasto niente, dice. Resta solo la testimonianza orale. Tutto il romanzo, tutta la ricostruzione storica, si basa sull’oralità. E cosa sente Scego scrittrice rispetto a questo? “…i nostri antenati non hanno conosciuto la lingua scritta e non penso che chi ha le risorse e l’istruzione per imparare a scrivere sia migliore degli altri: ma vi ringrazio di avermi fatto dono di questo strumento invisibile e potente, perché tramite esso canto la nostra gente.”
“…l’autobiografia è affascinante per il suo costruirsi in costante movimento. Il passato non è mai fermo, segue i nostri cambiamenti”, scrive Scego nei ringraziamenti. E questo vale per tutti. Perché, alla fine, ci si accorge che quella che si è letta non è solo la storia degli Scego. È anche la nostra.

“Come si fa a dire a sé stessa di aver amato il male?”, è questa la domanda delle domande, la pietra d’inciampo, l’abisso che non si vuole vedere. Le protagoniste de “Le Pentite” di Francesca G. Marone (Les Flaneurs edizioni) arrivano a formularla e riescono anche ad elaborarla, ma solo dopo un percorso lungo quasi una vita. E bisogna dire che a volte non ci si arriva affatto. Sono le donne, per lo più, a cadere nella velenosa tela di ragno dell’amore “malato”, cioè dell’amore per un uomo che fa del proprio potere sull’altro, dell’esercizio crudele della propria “forza” psicologica la ragione e il senso della relazione sentimentale.
Le storie di Federica e Maria, entrambe intrappolate dall’amore per lo stesso uomo violento, il Lupo, si intrecciano a quelle di Albina ed Elisa, donne del Settecento, ricoverate nell’Ospedale degli Incurabili. È qui, in questo meraviglioso luogo della Napoli storica, che si svolgono gli eventi, quelli presenti e quelli passati. Federica è una storica dell’arte, donna curata nell’aspetto ma apparentemente dimentica delle emozioni più coinvolgenti, che presenta un progetto per il recupero di una zona dell’antico complesso. Maria è una sua amica di vecchia data, che incontra casualmente in un supermercato, molto diversa da lei, semplice al limite della sciatteria. È subito chiaro che hanno condiviso un periodo molto intenso della vita. Delle donne del passato appare per prima Albina. È una giovane esile, stramba, che non parla, ma canta di notte e che viene internata (tanto più crudelmente quanto più l’iniziativa è travestita da amorevole preoccupazione) dalla madre e dal marito, che non ne possono più e vogliono vivere la loro vita allegramente e senza pesi. Elisa, invece, più grande di lei, è un’ex-prostituta ricoverata nel reparto delle Pentite, dove trovano accoglienza in cambio di lavoro le donne come lei che non hanno più mezzi di sopravvivenza. Saranno condannate a una morte terribile e che pure non riuscirà a strappare loro quello che hanno di più prezioso, un legame che supererà il tempo. Come il pozzo dei pazzi, l’ospedale, la farmacia, la spezieria, come l’intero complesso degli Incurabili, che accoglie le storie di questo romanzo, e attraversa il tempo, fonde passato e presente e sembra, infine, appartenere a una dimensione altra, quella, forse, dell’anima umana.
Ciò che accomuna i quattro personaggi è l’essere vittime di violenza (familiare, sociale, maschile) e l’amore, che le abita e, infine, le salva.
Come si può amare il proprio carnefice? Come mai non si riesce a uscire dalle relazioni tossiche? Troppo facile pensare alla dipendenza economica e alla paura fisica (che pure esistono e sono importantissime) o al condizionamento sociale (che sempre dispiega la sua forza). Tutte queste cose hanno il loro peso, ma è il legame d’amore il vero nodo, là dove veleno e cura si avvinghiano, si intrecciano, si fondono. È qui che Francesca G. Marone affonda il suo scandaglio, senza paura, con acutezza di visione, sensibilità e delicatezza. Con una scrittura che diventa sempre più intensa e coinvolgente man mano che la storia procede, l’autrice ci racconta le emozioni delle quattro donne e il loro vissuto, ci fa sentire le loro sensazioni, ci descrive i corpi e le azioni, mette il dito nelle loro ambiguità e nelle loro paure, nelle loro ferite aperte.
Nel romanzo un altro personaggio accompagna lo svolgersi delle due linee temporali, viaggiando, a sua volta, su una terza linea: Giuseppe Mosca, dottore appassionato e umano, ispirato a Giuseppe Moscati, che pure tanto lavorò agli Incurabili. Personaggio che fa da contraltare a Lupo e Mastrogiorgio, i due uomini violenti, ma anche in qualche modo simmetrico ai personaggi femminili, in quanto anche lui ha una ferita d’amore che non si sana e che lo rende più fragile, ma più empatico. Sono suoi i versi che scandiscono il racconto e lo illuminano.
Romanzo prezioso, frutto di un lavoro di ricerca storica e psicologica non comune, scritto in una lingua ricca e precisa, ma cangiante, che spazia dal realismo all’onirico, al poetico.
E se è l’amore che porta al dolore e alla perdita di sé, è l’amore, quando significa libertà e coraggio di essere sé stesse, che alla fine riporta alla vita, all’ombra del grande albero di magnolia nel cortile dell’Ospedale degli Incurabili.

I luoghi, apparentemente, sono spazi fisici. Almeno così ci piace pensare. Di conseguenza li si guarda con occhio a volte curioso, a volte indifferente. Persino, può capitare, che di un particolare luogo ci chiediamo a cosa deve la sua particolare forma, e se ci sono costruzioni o rovine ci interroghiamo sulla sua storia. Ma il nostro sguardo è spesso tanto superficiale da non vedere quasi nulla. E poi i luoghi non sono affatto solo spazi fisici. Basta leggere l’ultimo, bellissimo libro di Antonella Cilento “Solo di uomini il bosco può morire”, Aboca ed.
Aboca è un’azienda che dagli anni 70 si occupa di salute umana attraverso la medicina naturale, a partire dalla coltivazione delle erbe fino alla ricerca e alla editoria. Recentemente ha creato una collana, “Il bosco degli scrittori”, che si ripropone di raccontare il mondo a partire da un albero. Senza gli alberi non potremmo vivere, a loro dovremmo rispetto e gratitudine, ammirazione, anche, per come stanno al mondo e da molto prima della nostra comparsa sul pianeta. Accostarsi a un albero, osservarlo, dovrebbe essere simile a una preghiera, un momento di meditazione e contemplazione. Con questo stesso spirito dovremmo guardare i luoghi. Essere pellegrini, Wanderer romantici, sempre in cammino, alla ricerca della casa dell’anima. E non fa differenza se i luoghi sono familiari o estranei, perché ciascuno è sempre anche l’altro, rassicurante e perturbante allo stesso tempo.
In “Solo di uomini il bosco può morire” (il titolo è un verso di “Poema umano” di Danilo Dolci) Antonella Cilento racconta delle sue fughe, insieme al marito Paolo, lontano dal pazzo mondo durante il lockdown per Covid 19. Il suo rifugio, il luogo in cui perdersi per ritrovarsi è mitico e sacro: la Silva Gallinarum, la foresta di Cuma. Quando si arriva in zona, di solito si visitano gli scavi, si cerca l’antro della Sibilla, magari si va alla Casina Vanvitelliana sul Fusaro e di questa foresta a stento ci si accorge.
Ignorata, dimenticata, rigogliosa, sorprendente, che dire ricca di storia è dire poco, è invece davvero il luogo delle meraviglie. Perché non è solo un’area verde protetta. Si tratta di una foresta antichissima, testimone di tutta la nostra Storia. Sul lungo nastro di sabbia che la separa dal mare sbarcarono gli Eubei, portando l’alfabeto, poi Enea, per ascoltare i vaticini della Sibilla, come ci racconta Virgilio, i cui versi l’archeologo Amedeo Maiuri, il padre di Cuma, suo scopritore e protettore, fece scolpire su tabelle esplicative, spesso tanto rovinate da essere illeggibili.
Sullo specchio di mare su cui si affaccia la silva si combatterono battaglie che cambiarono il corso della Storia. Come quella del 474 a.C., cantata da Pindaro (!), che sancì la fine degli Etruschi e dei Persiani. E poi ancora si racconta dei Goti e del Ducato bizantino e dei Normanni e infine delle difese che inutilmente installarono fascisti e nazisti, prevedendo qui lo sbarco che invece ebbe luogo ad Anzio.
Adesso sulla spiaggia ancora corrono i cavalli, ma invece che dalle bighe, al di là dei magnifici gigli di Cuma che fioriscono sulle dune, sono guidati da calessini. E nel bosco trova rifugio umanità varia, dai femminielli in cerca di incontri ai raccoglitori di telline, a degli strampalati Sturmtruppen, ragazzi in tuta mimetica che giocano alla guerra sparando pittura. Molti sono i padroni con i loro cani e poi ci sono i custodi, che raccontano di quando le volpi si catturavano e si mangiavano. Una strada ferrata inutilizzata attraversa il bosco finendo in una stazione fantasma con uno splendido giardino di lavanda e rosmarino.
Il racconto del presente di questo luogo è preciso e impietoso: la plastica, la monnezza, l’incuria e l’abbandono sono protagonisti. Eppure di fronte al turismo di massa che imperversa poco più in là o all’impronta lasciata dall’edilizia turistica sulla costa di Castel Volturno (fino a lì si estendeva la Silva) viene da pensare che il fatto che questa foresta sia ignorata dai più è una benedizione, perché in qualche modo distorto la preserva da più profondi e irreversibili scempi. Sono sopravvissute addirittura delle fantastiche api blu, tipiche del luogo.
Antonella Cilento scrive di questi luoghi con grande sapienza, rimandando non solo alla storia e alla letteratura, come è solita fare, ma al fumetto e al cinema, con anche uno straordinario “montaggio incrociato” di scene dalla foresta contemporanea, coi tanto di animali e umani, e scene dal famosissimo “Rashomon” di Kurosawa Akira, uno dei film più amati.
Il territorio di cui ci racconta è fisico e spirituale, è un territorio in cui si può sparire, sciogliersi, in cui ad ogni passo si posa il piede sul suolo e si affonda in uno spazio in cui coesistono storia, letteratura, cinema, ma soprattutto il mondo esterno e quello interiore, fino a che il confine tra i due si perde, perché ci si rende conto che le due cose coincidono. Che “il nostro corpo è fatto d’ alberi e animali, che noi siamo il cielo, la terra, siamo le api blu della Foresta e il giglio di Cuma”.
Il libro si apre e si chiude con un’immagine potente della nostra transitorietà e inconsapevolezza, che denuncia senza sconti la nostra lontananza dallo spirito del mondo. Ma la strada che porta a ricongiungersi con esso e “vibrare di felicità”, ci ricorda Cilento, è ancora aperta.

“Di avere combattuto e perso. Questo conosciamo”
Piccolo e prezioso, questo volumetto, scrittura d’esordio di Ersilia Saffiotti. Non si tratta di un romanzo e nemmeno di una raccolta di racconti, anche se le storie ci sono e sono di quelle che aprono il sipario su una vita piena di amore, dolore, difficoltà e lotta. Si tratta, invece, di una raccolta di scritture, ben radicate nell’autobiografia, cioè nell’esperienza del vivere dell’autrice, in cui il Vesuvio, il grande e terribile padre di noi napoletani, gioca il ruolo fondamentale di interlocutore, nella forma nobile del dialogo, come dice nella bella postfazione Ferdinando Tricarico. Il Vesuvio parla e risponde all’io narrante, che chiama amorevolmente Nennella, secondo il modello della filosofia antica, cioè per procedere verso la conoscenza di una qualche verità. Quale è presto detto: la verità su sé stessa e sul proprio rapporto col mondo.
La scrittura di Ersilia Saffiotti è densa, va dritto al punto e il punto è la propria esperienza emotiva. All’inizio leggiamo che “si scrive più con la pancia che con la testa” e che “la storia viene dal sangue, la impasti sangue e criscito e la metti a riposare”. Quindi per scrivere una storia bisogna scorticarsi, fare uscire il sangue, non cedere all’impressione e mettersi a guardare.
E nelle storie, come incastrando tessere di un mosaico, possiamo intravedere immagini, punti focali, snodi di un’esistenza.
La protagonista è una “runner”, cioè corre. È la prima cosa che apprendiamo. Poi scopriamo che ha iniziato a correre per smettere di fumare e che fumava perché il fumo aiuta a ingoiare tutto quello che non si vorrebbe. Scopriamo che di professione è avvocata, di quelli che ama la giustizia e difende i derelitti. Che è una donna che non riesce a passare davanti a una persona che piange senza fermarsi. Che c’è una malinconia sempre presente e che “la malinconia è il rammarico di non poter contenere tutto…” , e senza la malinconia “non riusciresti ad amare profondamente le persone”.
Il racconto di una causa, vinta eppure persa, resta centrale in questo libro, constatazione amarissima eppure non disperata di un mondo che ostinatamente non va come vorremmo, nonostante, con tutte le nostre forze, lottiamo per realizzarlo. “Di avere combattuto e perso. Questo conosciamo”.
Tutto con Napoli non solo sullo sfondo, ma presente e viva, città con cui continuamente la narratrice interagisce, senza farne idolo svuotato di realtà o ritratto iper-realistico ugualmente falso. Tutto con la lingua napoletana usata naturalmente come la propria lingua (c’è anche un bellissimo decalogo per il runner, tutto in napoletano) e naturalmente mescolata all’italiano.
Nella curatissima edizione di Colonnese i dialoghi col vulcano sono undici, undici episodi arricchiti di una pagina introduttiva, poetica ed evocativa, costituiti da una frase, che poi ritroveremo leggendo, e da un piccolo disegno di Gaetano Gravina, che annunciano il racconto successivo.
Si tratta, alla fine, di una scrittura emozionale ed emozionante, come dice Gigliola De Feo nella prefazione qui “la scrittura scorre libera dall’anima alla penna”. Ed è per questo che al lettore arriva dritta al cuore.

Feltrinelli
Il male, che ormai lo sappiamo, è banale, non finisce quando finisce la sua azione visibile. Il male che la guerra e i suoi orrori seminano non finisce con la fine della guerraApri
“Perché ti ho perduto” di Vincenza Alfano

Giulio Perrone Editore
Un affondo nella poesia di Alda Merini. E quindi un affondo nella sua vita, nel suo dolore, nella sua follia.Apri

“Carbone” di Licia Pizzi,
Caffèorchidea ed.
È una domanda antica, ben nota alle donne, quella sull’amore: resterà? tornerà? L’uomo, naturalmente: il fidanzato, il marito, l’amante. Una domanda che le donne pongono alle carte, alle indovine, ai palmi delle mani. Vera la pone all’acqua. Riempie un catino e quando arriva il momento giusto, l’istante preciso che solo lei individua, lancia il sasso del destino. Legge il percorso che fa per affondare, i cerchi che produce. E non può essere un’acqua qualsiasi. Il rituale è preciso e deve essere rispettato. Deve essere
“… l’acqua del pozzo più vicino. O acqua piovana raccolta da voi. Deve essere acqua che viene dalla prossimità. Quella che scorre sotto di voi, intorno a voi, insomma. Il fiume è troppo lontano. E là ci stanno i sentimenti di tutto il paese…”
No, l’uomo non tornerà. Raramente tornano. Lei lo sa bene, essendo stata la sua vita un percorso di lutti e di abbandoni precoci. Sua madre aveva un braccio torto e nessuno la voleva finché è arrivato un forestiero, un lituano detto “il russo”, che se l’è presa come moglie e come serva, che la differenza non c’era. È dalla madre che Vera ha imparato a leggere l’acqua, è un’arte che si trasmette di madre in figlia. Vera, adesso che è anziana e sola, legge l’acqua e fa le faccende per Armida, pianista talentuosa, concertista di fama, che è tornata dall’America e concerti non ne fa più. Non può: in Venezuela è successo qualcosa alle sue mani.
Con una scrittura forte, incisiva, essenziale Licia Pizzi racconta la vita quotidiana di queste due donne, il dipanarsi della loro relazione, che ha una superficie cheta (come l’acqua del catino) e una vita sotterranea che arde di un fuoco segreto, invisibile agli altri.
“Il carbone è denso e avvolgente, è un universo a sé. Sa cacciar via la luce e sporcare le pareti. Sa tirarsi dietro tutte le tinte, e chiudere il respiro in un patto perverso di Shh, è cosa che non deve essere detta ad anima viva. Assorbire i segreti. Come vera sa fare bene anche lei.
Quando lo sistema nella stufa, fa persino uno sbuffo invece del crepitio rassicurante del ciocco. Quante cose ha imparato. Le differenze, innanzitutto.
Il bruciare ipnotico della legna del focolare, nel quale vai sempre vicino e più vicino ancora, quello impaziente del sacco di juta nell’alba che ti minaccia, e quello ambiguo del carbone.
Ci sono molti modi di bruciare.”
Armida e Vera vivono insieme, nella vecchia casa familiare di Armida in vico Paradiso, nel suo paese d’origine, da dove il padre partì in cerca di fortuna per le Americhe. Vera è la sua governante, l’accudisce, la cura, la sostiene. Ma il legame tra le due è molto più di questo, più potente, più profondo. Sono due donne danneggiate dalla vita, private dell’amore e del bene, che nel loro sodalizio trovano non solo tranquillità, ma rivalsa, non solo aiuto e supporto, ma opportunità. Rimettere le cose a posto non si può, ma dare un aiutino al destino sì, riscriverlo, non solo leggerlo nell’acqua e subirlo.
Armida, abbandonata sull’altare, non si fa mancare gli amanti, anche ora, nell’età della maturità. Abituata a vivere sul palcoscenico non può farne a meno. La collana, l’abito, il corsetto, le ciabatte di seta. Anche negli anni bui della povertà. Leonida Laguardia è, in paese, il fascista più in vista, fa carriera, diventa podestà, ed è affascinato da Armida perché in lei tutto rappresenta il proibito: la moda francese (quando le cose da oltre confine sono, tutte, guardate con sospetto), la donna mai sposata e mai madre, il mistero del ritorno dal luogo favoloso per eccellenza. Armida per Leonida è la trasgressione, perché contravviene ai dettami dell’ideologia che alla luce del sole strombazza e afferma con violenza. Ma è nell’ombra che cerca di appagare i suoi bisogni, calmare le sue inquietudini. È un piccolo uomo che si sente grande esercitando violenza, con la copertura di un’ideologia e un partito che glielo consentono.
“Il paese era già il suo cortile, pensava Leonida.
E insomma erano, che lo negassero o meno:
Nemici della patria, colpevoli di cospirazione e complotto. E bastardi!
Così venne decretato dal processo sommario ai fuorilegge.
Erano repubblicani.
Erano comunisti.
Erano anarchici.
Erano sodomiti. Avevano tutte le più orrende colpe.
A Leonida piaceva l’aperta campagna per questo tipo di giustizia”
Tassello dopo tassello Pizzi costruisce la scena in cui questi tre personaggi si muovono, le storie individuali da cui provengono, le loro relazioni, le pulsioni intime e segrete.
Un’invasione di topi, un carbonaio che sembra venire da un altro tempo, un paese silenzioso, di gente chiusa in casa tra paura e indifferenza, la musica, Bach e Mozart, gli spartiti e un elenco che non si trova. “Madame Bovary” sempre sul comodino, la sua morte per avvelenamento da arsenico, il “verde di Parigi”. Al centro di tutto il rapporto tra Vera e Armida. Vera è l’adulta, si prende le responsabilità dei lavori pesanti e sporchi. In una scena memorabile ammazza un ratto con un colpo di scopa. Lo fa per la “signorina”, come la chiama, che protegge a tutti i costi, come se fosse sua madre.
Armida è un’Emma al rovescio: una donna che ha avuto la bella vita, il successo, la non mediocrità e poi l’ha persa, per colpa non di un uomo solo, ma di più d’uno. Sempre uomini, però, che hanno tradito la sua fiducia, l’hanno abbandonata. E l’abbandono è il male assoluto, originario, imperdonabile. Ma il destino di Armida non è quello di Emma.
“Carbone” ricorda Angela Carter e le sue riscritture delle fiabe. Anche questo libro è una favola nera, che parla della solitudine, del bisogno d’amore, dell’indifferenza e del conformismo che determinano l’isolamento di chiunque non sia “uguale”. E della volontà di sopraffazione e dell’acquiescenza al potere che generano mostri.
Ricevi i miei nuovi articoli nella tua casella di posta

Informazioni
Ciao, sono Mara Fortuna, ho fondato e presiedo l’associazione La Principessa Azzurra APS. Sono insegnante e scrittrice. Mi occupo di educazione ai sentimenti e di letteratura.

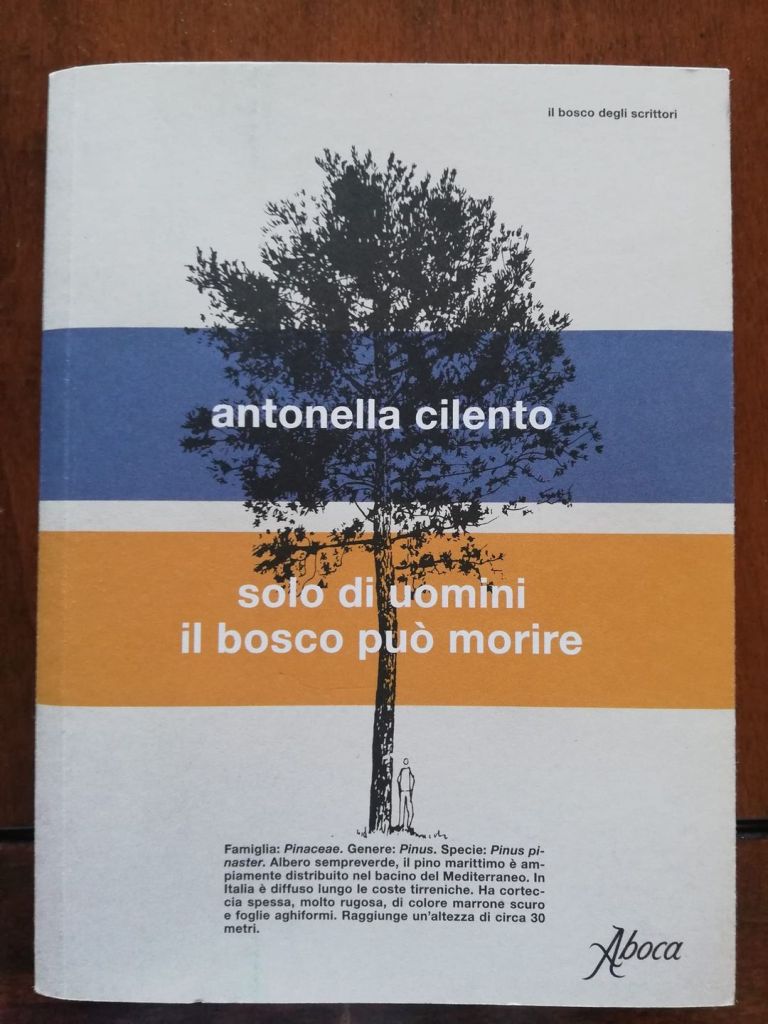


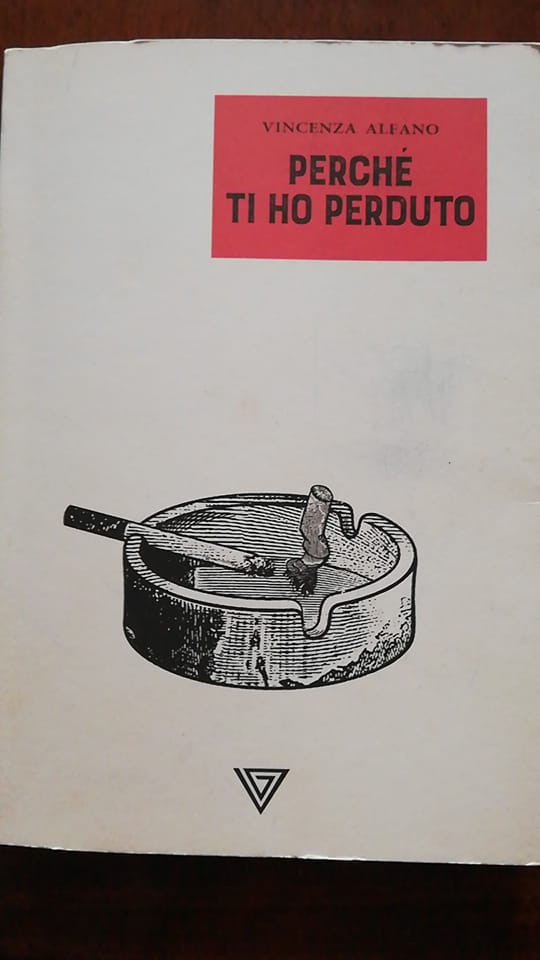
Lascia un commento